RECENSIONE - I VICERÉ di Federico De Roberto
- Alessandra Spanò
- 29 ago 2025
- Tempo di lettura: 4 min
I Viceré si colloca nel quadro del Verismo italiano, ma ne sovverte alcuni assunti fondamentali. Se il Verga dei Malavoglia o di Mastro-don Gesualdo tende a inscrivere il destino individuale entro un quadro naturalistico e collettivo, De Roberto assume la stessa impersonalità come punto di partenza per un’analisi radicale del potere. Il romanzo non è dunque soltanto verista, ma si innesta nella tradizione del grande realismo europeo, avvicinandosi per ambizione strutturale a Manzoni, Balzac e Stendhal.
L’universo narrativo creato da De Roberto si radica nella Catania ottocentesca, ma non si limita a una descrizione documentaria. La città e i suoi spazi diventano teatro allegorico della decadenza aristocratica, mentre la Sicilia intera si configura come microcosmo della storia nazionale. Gli ambienti interni, descritti con una minuzia quasi ossessiva, si caricano di valori simbolici: i palazzi degli Uzeda sono mausolei del potere, luoghi dove la monumentalità architettonica contrasta con la decadenza morale. L’intero mondo narrativo è costruito per mostrare l’irriducibile permanenza di una logica di dominio, che sopravvive ai mutamenti storici esteriori.
La struttura del romanzo è insieme lineare e centrifuga. Da un lato, si segue la progressiva dissoluzione della casata; dall’altro, la narrazione si frammenta in episodi che danno vita a un racconto corale, privo di un protagonista unitario. Questo procedimento ha una duplice valenza: da un lato restituisce la pluralità dei punti di vista che costituiscono il corpo sociale della famiglia; dall’altro dissolve l’illusione di un percorso teleologico o di un destino eroico. La coralità si pone come dispositivo critico, volto a smascherare la falsità delle narrazioni progressiste e patriottiche coeve.
La trama de I Viceré può essere sintetizzata nella cronaca di una lenta ma inesorabile erosione: la morte della principessa Teresa, le dispute ereditarie, i matrimoni di convenienza, le conversioni e i tradimenti politici. Tuttavia, l’intreccio non si sviluppa secondo la logica della suspense, bensì attraverso un accumulo ossessivo di conflitti interni e meschinità quotidiane. Questa scelta narrativa produce una sensazione di stagnazione, che rispecchia la visione ciclica della storia proposta dall’autore: nulla realmente cambia, se non le forme esteriori della lotta per il potere.
La famiglia Uzeda è rappresentata come una dinastia in via di dissoluzione, ma dotata di straordinaria resilienza. I personaggi incarnano una fenomenologia del potere. Il principe Giacomo è la personificazione della cupidigia, incapace di concepire il mondo al di fuori dell’ossessione patrimoniale. Donna Ferdinanda rappresenta l’avarizia declinata al femminile, crudele e calcolatrice. Il giovane Consalvo, invece, incarna il trasformismo politico: capace di tradire i Borboni per abbracciare l’Italia unita, si fa simbolo di un’Italia che sopravvive a sé stessa mutando pelle ma non sostanza.
I temi centrali si condensano attorno a tre nuclei. Primo: la decadenza dell’aristocrazia come immagine del declino di un’intera classe dirigente. Secondo: il trasformismo come logica dominante della storia italiana, per cui ogni mutamento si risolve in continuità di potere. Terzo: l’illusione del progresso, che viene decostruita e smascherata attraverso la ripetizione ciclica degli stessi vizi. In questo senso, I Viceré anticipa categorie critiche che saranno poi sviluppate dalla storiografia politica, dal concetto di “gattopardismo” fino alle analisi del trasformismo parlamentare. Il trionfo politico di Consalvo nel finale sigilla la visione amara di De Roberto. Se il lettore si attende la rovina totale della famiglia, il romanzo mostra invece come il potere, lungi dal dissolversi, sappia rigenerarsi. Consalvo non è un erede decaduto, ma un trasformista che si adatta al nuovo contesto politico, incarnando la sopravvivenza del privilegio aristocratico all’interno del nuovo Stato unitario. Il finale, quindi, ha una funzione meta-storica: suggerisce che la storia italiana non è evoluzione, ma reiterazione di schemi di dominio.
La lingua di De Roberto si colloca a metà strada tra il registro realistico e la deformazione grottesca. L’uso del discorso indiretto libero, dei dialoghi taglienti e delle descrizioni minuziose concorre a costruire un tono insieme clinico e corrosivo. L’impersonalità verista è mantenuta, ma l’ironia corrosiva del narratore tradisce una tensione polemica che lo avvicina più a Flaubert che a Verga. Il lessico è scelto con una precisione chirurgica, capace di rendere tanto la fisicità della decadenza quanto la crudeltà psicologica dei rapporti di potere.
L’esperienza di lettura è segnata da una duplicità: da un lato, la fascinazione intellettuale derivante dall’acume analitico; dall’altro, il senso di oppressione e asfissia morale. De Roberto non concede alcuna identificazione positiva, né alcuna catarsi. Il lettore è posto di fronte a uno specchio deformante, costretto a riconoscere nella vicenda familiare degli Uzeda la persistenza di logiche che non appartengono solo al XIX secolo, ma che attraversano la storia italiana fino alla contemporaneità.
I Viceré rappresenta un caso unico nel panorama letterario italiano: un romanzo che supera i confini del Verismo, anticipando categorie critiche della modernità. Nella genealogia letteraria nazionale esso appare come il grande romanzo della disillusione, contraltare e al tempo stesso complemento al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. L’opera di De Roberto, pur meno accessibile sul piano della leggibilità, è più radicale sul piano dell’analisi politica. Il suo lascito consiste nella capacità di mostrare che la letteratura non solo può, ma deve farsi strumento di smascheramento ideologico, restituendo alla narrativa la funzione critica di svelare la verità dietro le maschere del potere.





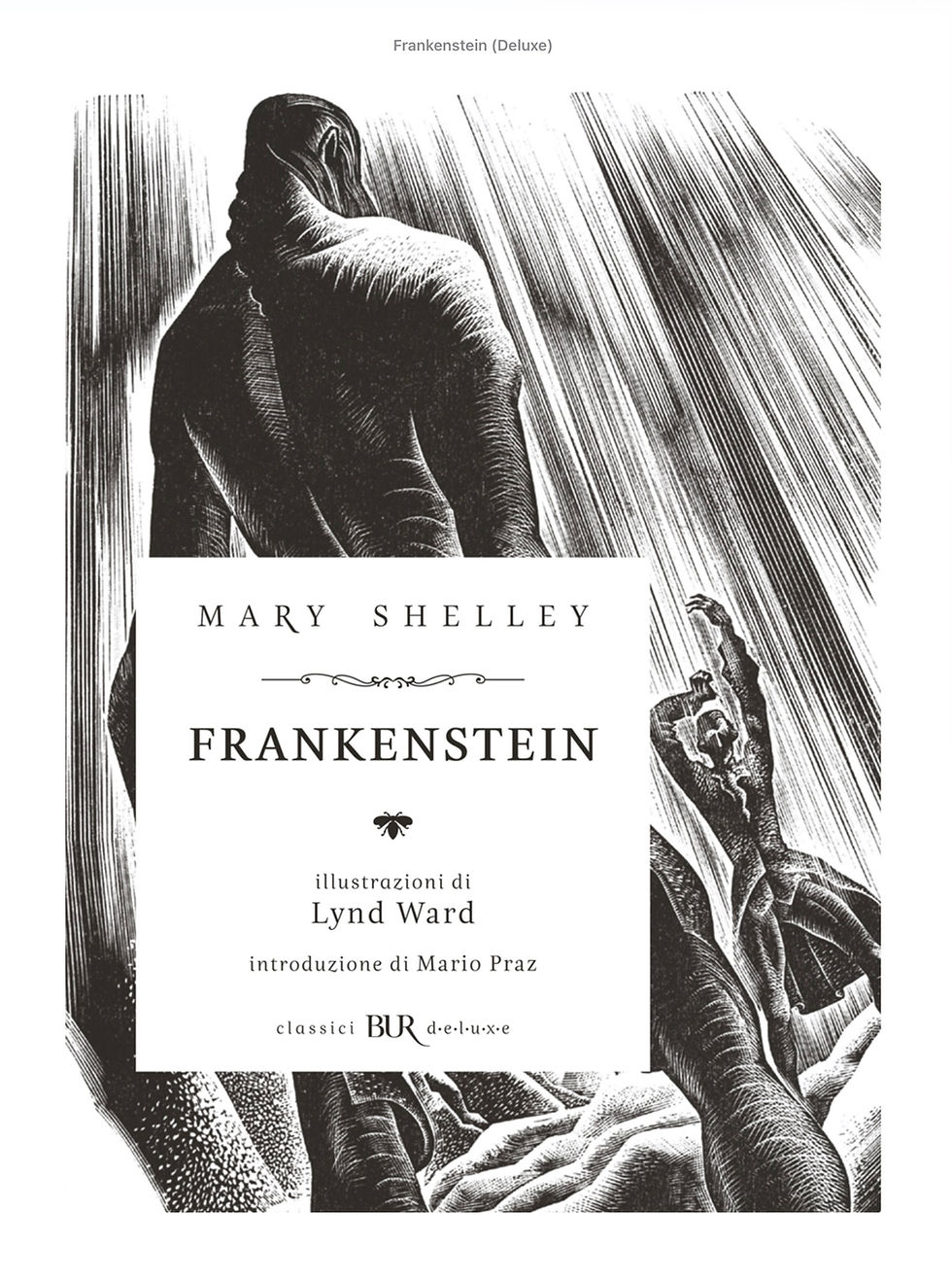

Commenti