RECENSIONE - Stalingrado di V. Grossman
- Alessandra Spanò
- 25 lug 2025
- Tempo di lettura: 4 min
L’opera di Grossman si colloca nella tradizione del romanzo storico di guerra, ma trascende le convenzioni del genere per assumere le dimensioni di un’epopea moderna. L’autore attinge alla lezione tolstoiana di Guerra e pace, sviluppando tuttavia una prospettiva narrativa che incorpora gli sviluppi della prosa novecentesca. Il romanzo si configura come un ibrido tra cronaca giornalistica - Grossman fu corrispondente di guerra per “Stella Rossa” - e narrazione epica, creando un unicum nella letteratura sovietica che anticipa e supera i limiti del realismo socialista attraverso una rappresentazione non ideologizzata della realtà bellica.
Il mondo narrativo di Stalingrado si articola su multiple dimensioni spaziali e temporali che convergono nell’assedio della città sul Volga. Grossman costruisce un universo narrativo che abbraccia simultaneamente la dimensione dell’esperienza individuale e la dimensione della Storia del secondo conflitto mondiale. La geografia urbana di Stalingrado diventa un personaggio a sé stante, con le sue fabbriche, i suoi quartieri residenziali trasformati in fortezze, il fiume che divide e unisce. L’autore dimostra una straordinaria capacità di orchestrare la complessità del reale, alternando prospettive che spaziano dai bunker tedeschi alle trincee sovietiche, dagli appartamenti borghesi ai laboratori scientifici, creando un affresco totale della condizione umana in guerra.
La struttura architettonica in Stalingrado riflette la complessità della materia narrata attraverso una composizione polifonica che alterna sequenze narrative di diversa natura e intensità. Grossman giustappone, come in un film, scene di battaglia a momenti di riflessione filosofica, ritratti individuali a panorami collettivi. La narrazione procede per onde concentriche che si allargano e si restringono attorno al nucleo centrale dell’assedio, creando un ritmo che mima l’alternanza di tensione e attesa propria dell’esperienza bellica. La divisione in capitoli non segue una logica cronologica lineare, ma privilegia una progressione tematica che consente all’autore di esplorare le diverse sfaccettature del conflitto.
Grossman in Stalingrado rifiuta la tipizzazione ideologica per creare figure umane di straordinaria complessità psicologica. Viktor Štrum, il fisico nucleare, incarna la figura dell’intellettuale che deve confrontarsi con le contraddizioni del sistema sovietico e le pressioni della guerra. La sua evoluzione rappresenta il percorso di una coscienza che si dibatte tra fedeltà ideologica e verità scientifica. Krymov, il commissario politico, attraversa una crisi che lo conduce a interrogarsi sui fondamenti del proprio credo. I personaggi femminili, da Ljudmila Nikolaevna a Vera, sono ritratti con una profondità che supera gli stereotipi della letteratura sovietica, mostrando la complessità dell’esperienza femminile in tempo di guerra. Anche i personaggi tedeschi sfuggono alla caricatura propagandistica, emergendo come esseri umani intrappolati nelle maglie della Storia.
Stalingrado esplora temi di portata universale che trascendono il contesto storico specifico. Il tema centrale è quello della resistenza umana di fronte all’oppressione, declinato tanto nella dimensione militare quanto in quella spirituale e morale. Grossman indaga la natura del totalitarismo, mostrando come nazismo e stalinismo condividano meccanismi oppressivi analoghi. Il tema della libertà emerge come valore fondamentale che si manifesta nei gesti quotidiani di solidarietà e resistenza. L’autore esplora inoltre il rapporto tra individuo e Storia, mostrando come gli eventi epocali si riflettano nell’esperienza personale, trasformando e rivelando la natura profonda degli esseri umani. Il tema della memoria si intreccia con quello della verità storica, in una riflessione che Grossman riprenderà in Vita e destino.
Lo stile di Grossman si caratterizza per una prosa di straordinaria potenza evocativa che unisce precisione documentaria e intensità lirica. L’autore padroneggia una gamma espressiva che spazia dal registro colloquiale a quello elevato, dalla descrizione naturalistica alla riflessione filosofica. La tecnica del discorso indiretto libero consente di penetrare nella coscienza dei personaggi senza ricorrere a espedienti artificiali. L’uso del presente storico in alcune sequenze dona immediatezza alla narrazione, mentre l’alternanza dei punti di vista crea un effetto di polifonia che arricchisce la prospettiva complessiva. Le descrizioni paesaggistiche e ambientali rivelano una sensibilità pittorica che trasforma la desolazione bellica in visioni di struggente bellezza.
Ciò che più colpisce in Stalingrado risiede nella straordinaria capacità di Grossman di coniugare dimensione epica e profondità psicologica, creando un affresco della condizione umana in guerra che non ha eguali nella letteratura del Novecento. La complessità della costruzione narrativa, lungi dal risultare artificiosa, riflette la complessità del reale e consente all’autore di esplorare tutte le sfaccettature del suo argomento. L’onestà intellettuale con cui Grossman affronta i temi più scottanti, evitando il più possibile le semplificazioni ideologiche, costituisce uno dei pregi maggiori dell’opera.
Stalingrado ha la capacità di trasformare gli eventi storici in esperienza vissuta, coinvolgendo il lettore in un percorso di identificazione e riflessione che trascende la dimensione puramente letteraria. La rappresentazione della sofferenza umana evita tanto il sentimentalismo quanto l’indifferenza, raggiungendo un equilibrio che consente di affrontare anche gli aspetti più drammatici della guerra senza cadere nel compiacimento del dolore. L’emozione nasce dalla tensione tra la apparente grandezza degli ideali e la fragilità dell’esistenza umana, dalla consapevolezza che la Storia si incarna in destini individuali che meritano di essere ricordati e compresi.
Stalingrado di Vasilij Grossman rappresenta una delle vette della letteratura del XX secolo. L’autore ha creato un monumento letterario che trascende i limiti del genere bellico per assumere le dimensioni di una riflessione universale sulla condizione umana. La capacità di Grossman di mantenere uno sguardo lucido e pietoso sui propri personaggi, evitando tanto l’idealizzazione quanto la demonizzazione, conferisce all’opera una dignità morale che la rende imprescindibile per la comprensione del Novecento.


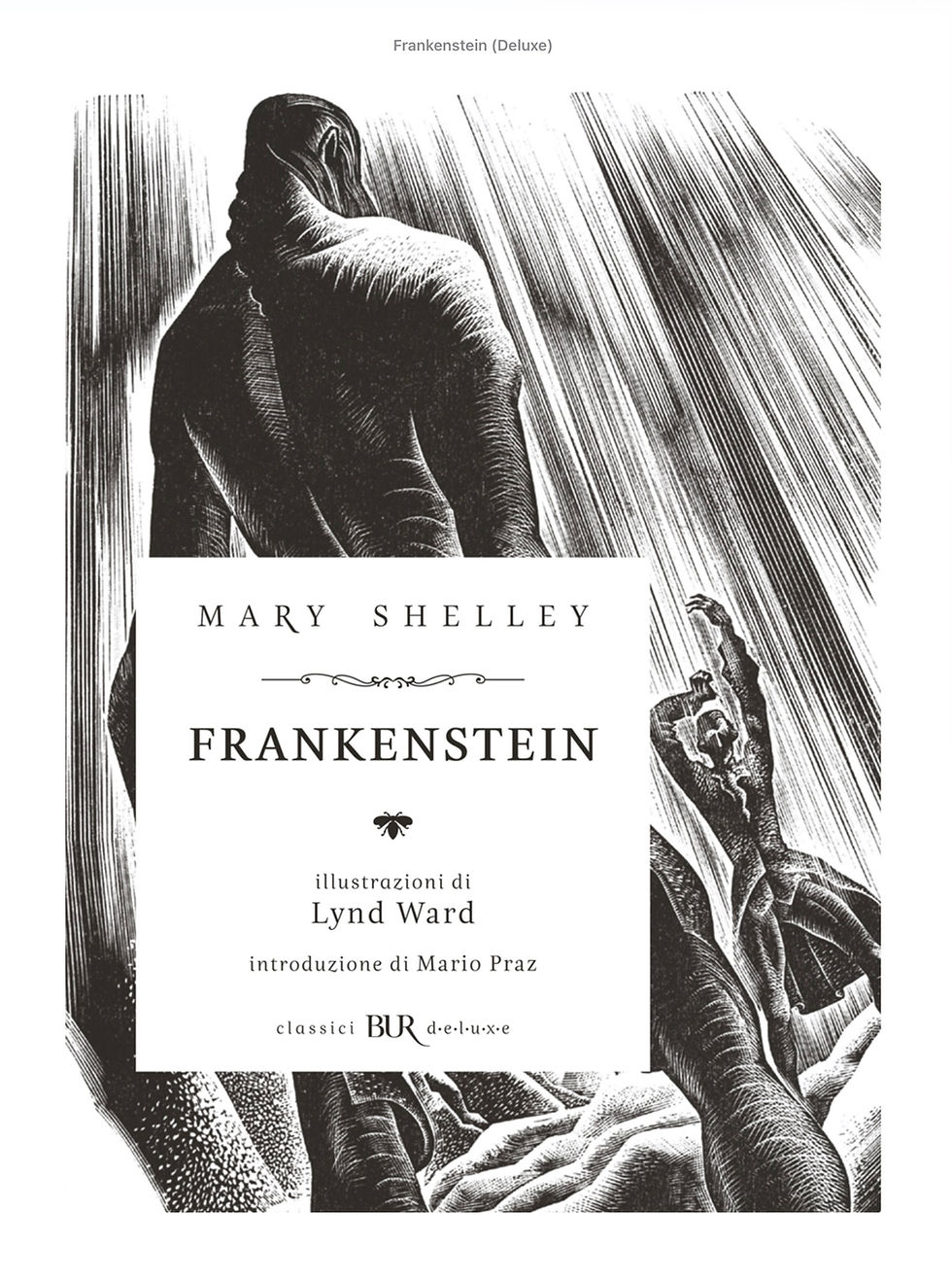

Commenti