RECENSIONE - Vita e Destino di Vasilij Grossman
- Alessandra Spanò
- 8 ago 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Vita e Destino si colloca nella tradizione del romanzo totale ottocentesco, dialogando direttamente con Guerra e Pace di Tolstoj, ma superandone i limiti attraverso una modernità narrativa che incorpora il nuovo modo di raccontare proprio del Novecento. Grossman costruisce un’epopea che trascende i confini del romanzo storico tradizionale per diventare una meditazione filosofica sulla condizione umana nel XX secolo. L’opera si configura come un gigantesco romanzo di formazione collettivo, dove non è il singolo protagonista a formarsi, ma un’intera civiltà che si confronta con la propria dissoluzione.
Vita e Destino nasce come prosecuzione di Stalingrado, ma ne costituisce al tempo stesso una radicale riscrittura ideologica. Se il primo romanzo rimaneva ancora (se così si può dire viste le numerosissime censure e tagli cui il manoscritto fu sottoposto per ben sei volte) entro i confini dell’ortodossia sovietica, celebrando l’eroismo del popolo russo, il secondo compie una svolta critica che ne determinerà nuovamente la censura. La relazione tra le due opere è dialettica: Vita e Destino non rinnega il patriottismo di Stalingrado, ma ne mette in luce le contraddizioni. I personaggi che ritornano dal primo romanzo subiscono un’evoluzione che li porta a interrogarsi sui fondamenti ideologici che avevano dato senso alla loro lotta. La famiglia Šapošnikov, fulcro narrativo di entrambe le opere, diventa il prisma attraverso cui Grossman riflette sul passaggio da una visione eroica della guerra a una concezione tragica della Storia. lo studio critico fra le due componenti del dittico di Grossman rivela come l’autore abbia utilizzato la continuità narrativa per costruire una discontinuità di senso, trasformando l’epopea patriottica in requiem per le illusioni del socialismo reale.
L’universo narrativo di Vita e Destino si estende su una geografia che va dal fronte di Stalingrado ai campi di concentramento, dalle steppe russe alle stanze del potere moscovita. Grossman costruisce un mondo dove la Storia con la maiuscola schiaccia le esistenze individuali, ma dove paradossalmente emerge la resistenza dell’umano. La rappresentazione dell’Unione Sovietica del 1942-1943 non è meramente documentaria: Grossman crea una realtà densa di simboli, dove ogni spazio geografico corrisponde a una dimensione morale. Il laboratorio di fisica diventa metafora della ricerca della verità, Stalingrado si trasforma nel crocevia dove si decidono i destini dell’umanità, lager e GULag rappresentano l’abisso verso cui precipita la civiltà occidentale. La costruzione del mondo operata da Grossman in questa seconda parte del dittico rivela una concezione della Storia dove rimane sempre aperto uno spazio per la libertà individuale, quindi per la coscienza del singolo e la sua responsabilità.
Il centro dell'opera è pur sempre la battaglia di Stalingrado, evento-cardine attorno al quale gravitano tutte le vicende, ma la struttura scelta, quella a mosaico, permette a Grossman di realizzare una polifonia autentica, dove nessuna voce narrativa prevale definitivamente sulle altre.
Vita e Destino affronta dunque i nodi fondamentali dell’esperienza novecentesca attraverso una riflessione che investe simultaneamente la dimensione storica, politica, etica e metafisica. Il tema del totalitarismo viene analizzato nella sua duplice manifestazione nazista e sovietica, rivelando le inquietanti analogie tra i due sistemi.
Lo stile di Grossman si caratterizza per una prosa di trasparente chiarezza, che nasconde però una complessità strutturale di notevole raffinatezza. La tecnica del discorso indiretto libero permette all’autore di penetrare nella coscienza dei personaggi senza rinunciare alla distanza epica necessaria per abbracciare la totalità dell’esperienza storica. I registri stilistici si alternano virtuosamente, andando dal lirismo della riflessione privata alla durezza del reportage di guerra. Grossman utilizza inoltre la tecnica del montaggio parallelo per creare attraverso la giustapposizione di scene apparentemente eterogenee un insieme connessioni profonde che in tal modo illuminano il senso complessivo dell’opera. La descrizione naturalistica si alterna al simbolismo, creando una tensione stilistica che riflette la complessità dell’esperienza novecentesca. L’uso del presente storico nelle sequenze più drammatiche conferisce immediatezza alla narrazione, mentre l’impiego del discorso diretto permette ai personaggi di esprimere direttamente le proprie concezioni filosofiche.
La forza principale di Vita e Destino risiede nella capacità di coniugare l’ampiezza della visione storica con la profondità dell’analisi psicologica. Grossman riesce a creare un affresco della modernità che non sacrifica mai la dimensione umana all’ambizione totalizzante. La rappresentazione del totalitarismo raggiunge una lucidità analitica che fa dell’opera un documento imprescindibile per la comprensione del XX secolo. La costruzione dei personaggi rivela una maestria che attinge alla grande tradizione del realismo russo senza mai cadere nell'imitazione fiacca di modelli passati.
Grossman riesce a trasformare la tragedia collettiva in esperienza personale del lettore attraverso una scrittura che non indulge mai al sentimentalismo, ma che rivela una profonda compassione per la sofferenza umana. La rappresentazione della Shoah raggiunge momenti di intensità emotiva straziante senza mai cadere nella retorica dell’orrore. L’identificazione del lettore con i personaggi viene costruita attraverso la rivelazione graduale della loro umanità, anche quando questa si manifesta nelle circostanze più estreme. L’effetto catartico dell’opera nasce dalla capacità di Grossman di trasformare la disperazione storica in affermazione della dignità umana. Il lettore sperimenta simultaneamente lo smarrimento di fronte alla barbarie del XX secolo e la consolazione derivante dalla scoperta che l’umanità può sopravvivere anche nelle condizioni più avverse.
Vita e Destino si configura come l’opera che meglio ha saputo dare forma artistica all’esperienza totalitaria del XX secolo. Il dittico di Grossman si colloca tra i capolavori assoluti della letteratura mondiale, non solo per la sua qualità artistica, ma per la sua capacità di illuminare i nodi irrisolti della modernità. In un’epoca in cui il totalitarismo sembrava definitivamente sconfitto, Vita e Destino mantiene intatta la sua attualità, ricordandoci che la libertà è una conquista sempre precaria e sempre da rinnovare.
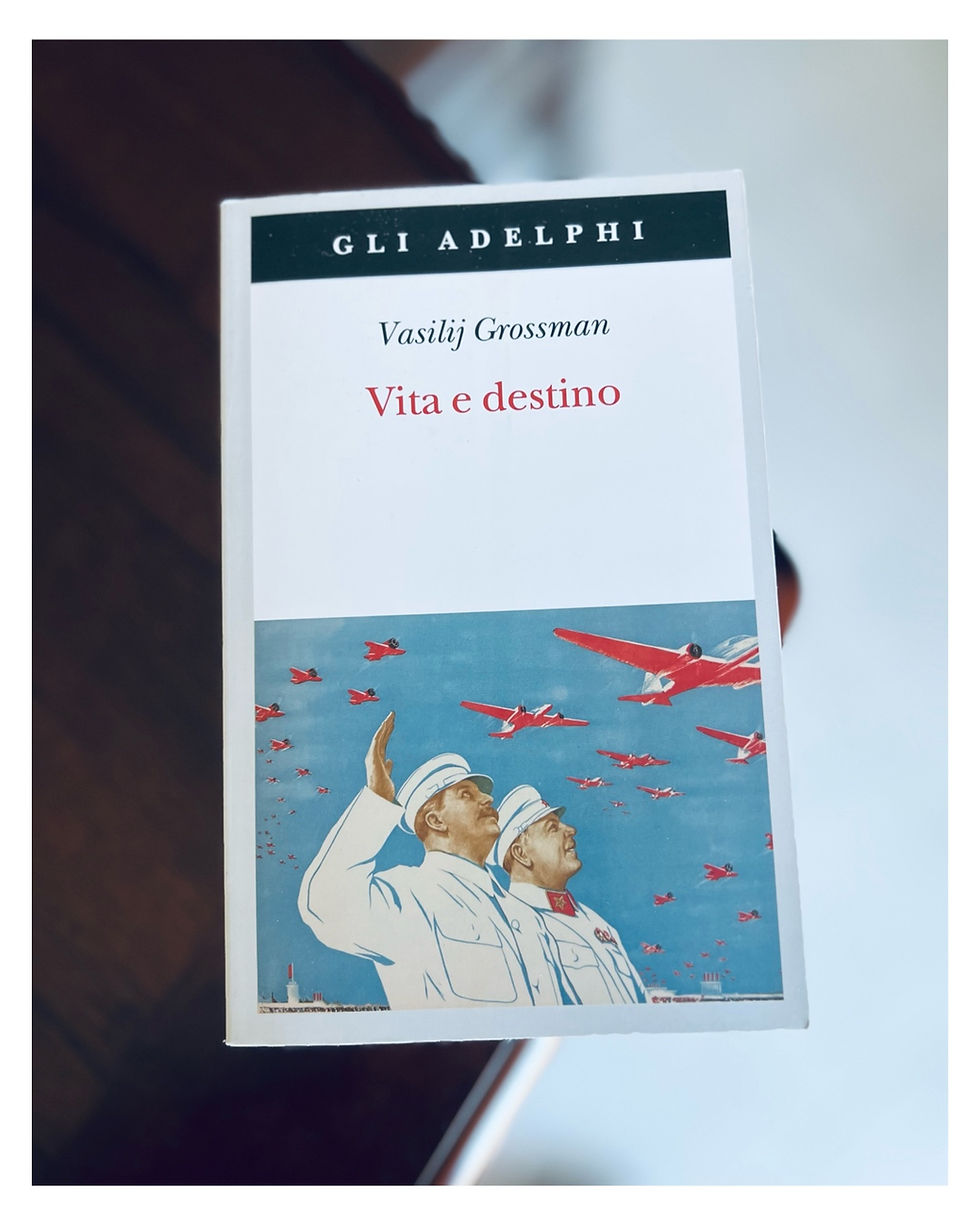

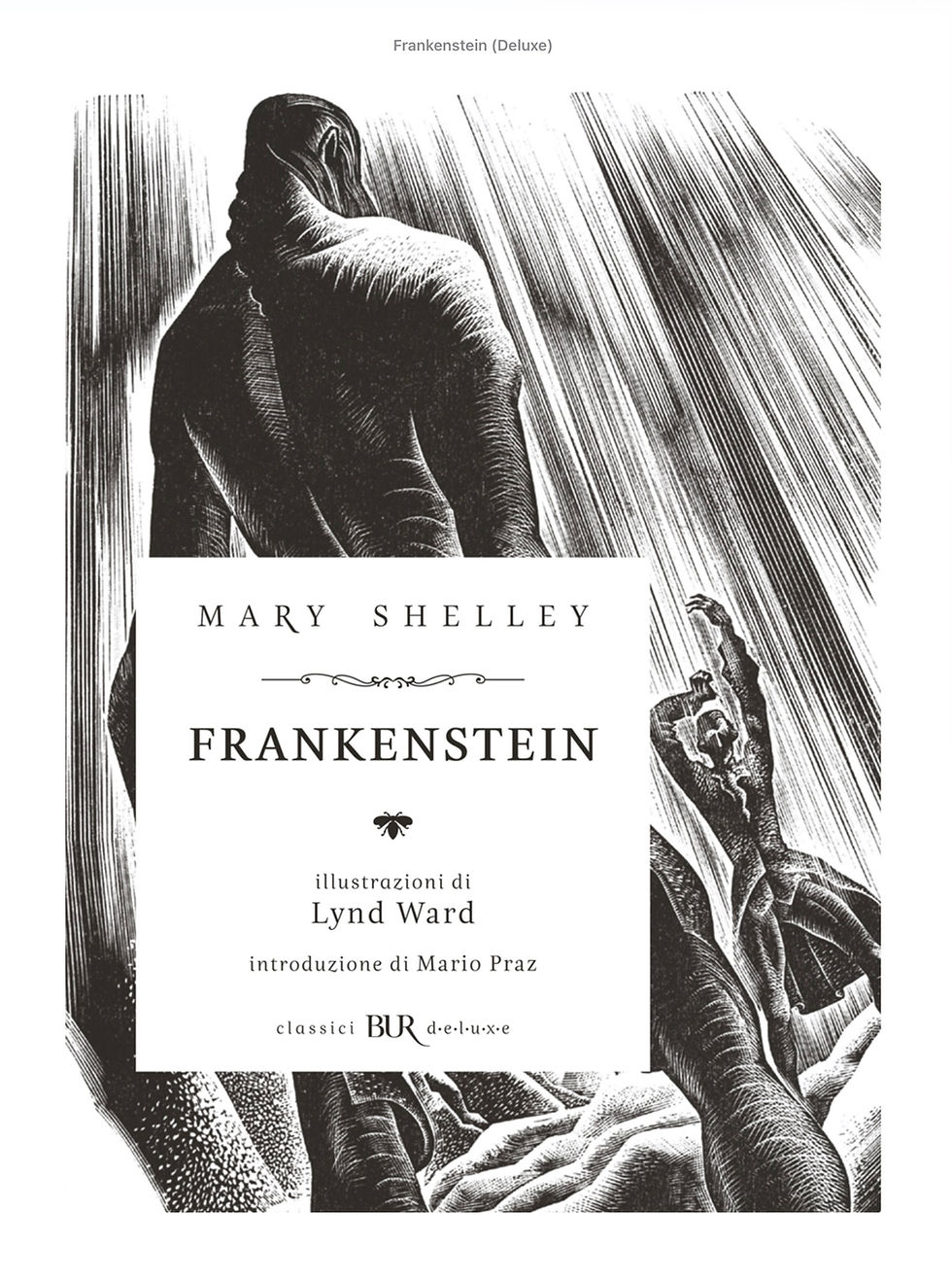

Commenti