RECENSIONE - Il giorno dell’ape di Paul Murray
- Alessandra Spanò
- 26 feb 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Paul Murray, autore irlandese noto per il suo talento nella satira sociale e nella costruzione di narrazioni corali, ha pubblicato The Bee Sting nel 2023, consolidando ulteriormente il suo status di scrittore di primo piano. Il romanzo, finalista al Booker Prize, si presenta come un’opera ambiziosa e stratificata, in grado di combinare il dramma familiare con una riflessione sulla crisi economica e sul destino umano. L’abilità di Murray nel manipolare la struttura narrativa e la voce dei personaggi offre un caso di studio significativo per chiunque voglia approfondire le tecniche della scrittura creativa.
La complessità dell’opera si manifesta nella sua costruzione polifonica, nella profondità psicologica dei protagonisti e nella capacità dell’autore di muoversi con fluidità tra i registri narrativi. Il giorno dell’ape infatti è un romanzo che sfugge a una classificazione netta, ma che si colloca principalmente nel solco del romanzo familiare e sociale, con forti elementi di commedia nera e dramma psicologico. La fusione di questi generi consente a Murray di esplorare sia la dimensione individuale che quella collettiva, intrecciando le vicende personali dei protagonisti con il contesto socio-economico più ampio.
Pur avendo radici nel romanzo realista, il testo si avvale di una struttura sperimentale che lo avvicina alle narrazioni postmoderne. La voce polifonica, il frequente cambio di prospettiva e l’uso innovativo della punteggiatura e della sintassi conferiscono all’opera una qualità proteiforme che la distingue dai classici romanzi di costume.
L’ambientazione de Il giorno dell’ape è profondamente radicata nella contemporaneità irlandese e riflette un paese ancora segnato dalla crisi finanziaria del 2008. La cittadina in cui si svolgono le vicende è un microcosmo che riproduce le tensioni economiche, le disuguaglianze e le ansie della classe media in declino. La caratterizzazione degli ambienti — dalla concessionaria di automobili della famiglia Barnes alla campagna circostante, passando per le case che riflettono lo status socio-economico dei personaggi — è essenziale per comprendere il senso di precarietà e di disfacimento che permea il romanzo.
Murray utilizza lo spazio narrativo non solo come sfondo, ma come elemento attivo che influenza le azioni dei personaggi. Gli interni domestici, ad esempio, diventano simboli del fallimento familiare: la casa di Imelda e Dickie, una volta segno di prosperità, si trasforma in un luogo di decadenza, mentre il rifugio nel bosco rappresenta un’illusione di sicurezza e di fuga.
La narrazione de Il giorno dell’ape è costruita in modo da alternare le prospettive di diversi personaggi, con sezioni dedicate a ciascuno di essi. Questo approccio non lineare permette di rivelare gradualmente le informazioni, mantenendo un costante senso di tensione e ambiguità. Uno degli aspetti più peculiari della struttura è l’uso della narrazione in flusso di coscienza, in particolare nelle sezioni di Imelda, in cui la punteggiatura convenzionale viene spesso abbandonata, creando un effetto di urgenza e di disorientamento. Questo espediente stilistico non è solo una scelta formale, ma riflette anche lo stato mentale della protagonista, accentuando la sua confusione e il suo rifiuto di affrontare la realtà.
L’intreccio segue una progressione circolare, con continui rimandi tra passato e presente che contribuiscono a costruire una rete di significati interconnessi. La tensione narrativa cresce progressivamente, portando il lettore a riconsiderare costantemente le informazioni precedenti alla luce di nuove rivelazioni.
Paul Murray adotta ne Il giorno dell’ape una scrittura che bilancia con grande maestria diversi registri, oscillando tra il realismo dettagliato e una vena più sperimentale, che emerge in particolare nelle sezioni di alcuni personaggi. La fluidità con cui l’autore gestisce i cambi di stile e di prospettiva è uno degli elementi più distintivi del romanzo, contribuendo non solo alla profondità psicologica dei protagonisti, ma anche alla costruzione della tensione narrativa.
Tuttavia, l’opera presenta anche alcuni elementi che potrebbero essere percepiti come punti deboli, soprattutto da un pubblico meno incline alla sperimentazione narrativa. La lunghezza del romanzo, che supera le 600 pagine, può risultare eccessiva per alcuni lettori. Sebbene la struttura a più voci giustifichi l’ampiezza della narrazione, vi sono momenti in cui il ritmo rallenta e la tensione narrativa si diluisce. Alcuni passaggi, specialmente quelli più introspettivi, rischiano di apparire ripetitivi, e la gestione dell’alternanza temporale tra passato e presente, sebbene ben orchestrata, può richiedere un impegno cognitivo elevato.
Un altro elemento che potrebbe costituire un limite è la scelta di adottare registri linguistici fortemente differenziati tra le sezioni. Se da un lato questa strategia aumenta il realismo e la caratterizzazione dei personaggi, dall’altro potrebbe creare una discontinuità nella lettura, soprattutto per chi è meno abituato a passaggi così marcati tra stili e tecniche diverse. In particolare, la mancanza di punteggiatura nelle parti dedicate a Imelda può risultare ostica e disorientante, rallentando la lettura e richiedendo un’attenzione superiore alla media.
Infine, il finale aperto potrebbe lasciare molti lettori insoddisfatti ed in una deprimente crisi di incertezza. La tensione accumulata nel corso della narrazione non si risolve completamente, e la scelta di non fornire risposte definitive sui destini dei personaggi accentua il senso di incertezza e precarietà che permea l’opera. Inoltre il finale sembra proprio volutamente forzato ad una tale non-conclusione, mostrando eccessivamente la mano dell’autore, persino nello stabilire le condizioni meteo dell’ultima parte, che determinano ancora di più l’infausto finale. Questa ambiguità scoperta è sicuramente uno dei tratti distintivi dello stile di Murray, ma rappresenta un elemento eccessivamente divisivo tra il pubblico.


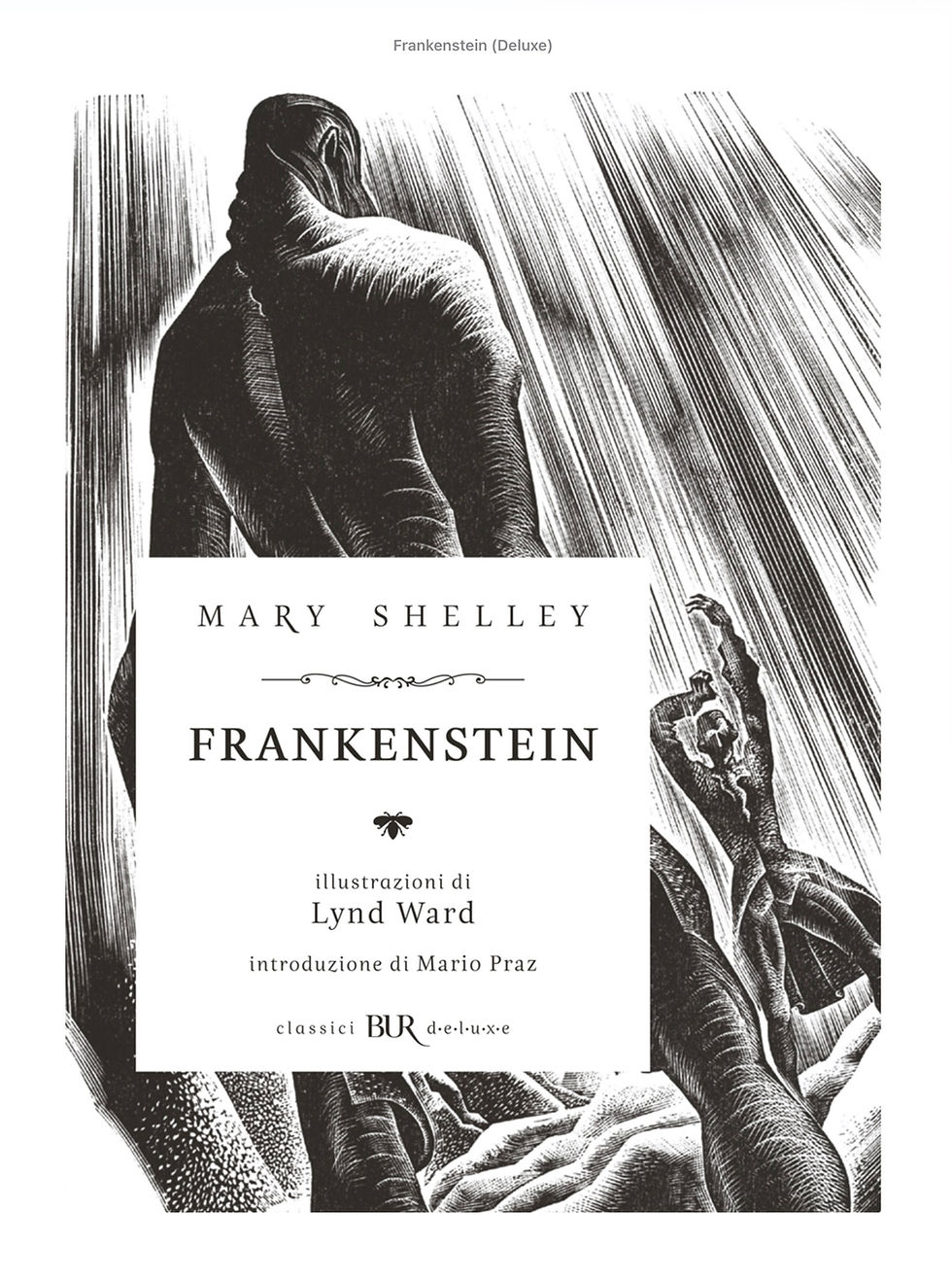

L'ho adorato!!!