RECENSIONE - Il nome della rosa di Umberto Eco
- Alessandra Spanò
- 15 giu 2025
- Tempo di lettura: 6 min
Il nome della rosa si configura come un’opera di straordinaria complessità generica, che trascende le tradizionali categorizzazioni letterarie per situarsi all’intersezione tra romanzo storico, giallo intellettuale e decostruzione postmoderna. L’opera si inserisce nel filone del cosiddetto “giallo metafisico”, dove l’investigazione poliziesca diventa pretesto per un’indagine più profonda sui meccanismi della conoscenza e dell’interpretazione.
L’ambientazione dell’abbazia benedettina nell’Italia settentrionale del 1327 (durante il conflitto fra il papa avignonese Giovanni XXII e l'imperatore Ludovico il Bavaro), rappresenta un microcosmo accuratamente orchestrato, dove ogni elemento architettonico, liturgico e culturale concorre a creare un universo autosufficiente e traboccante di significati simbolizzati. Eco dimostra una padronanza filologica che, tuttavia, non si limita alla mera ricostruzione erudita, ma piega il dato storico alle esigenze di una narrazione che mira a sostituire la realtà storica del Medioevo con una immagine di esso altamente ideologizzata. La biblioteca labirintica assume valore di metafora epistemologica, rappresentando simultaneamente il sapere umano nella sua totalità e la sua intrinseca inaccessibilità. L’abbazia diventa uno spazio alienus dove le leggi della logica e della razionalità si confrontano con l’irrazionale e l’inconoscibile.
La ripartizione in sette giornate riecheggia la struttura della creazione della Genesi, ma Eco sovverte il modello biblico, trasformando il sette in una progressione verso il caos e la distruzione, prendendo come canovaccio il libro dell'Apocalisse. Ogni giornata è ulteriormente suddivisa secondo le ore canoniche, creando un ritmo narrativo che mima la scansione temporale monastica mentre progressivamente la mina dall’interno. La struttura circolare dell’opera enfatizza il carattere autoreferenziale del testo e la sua natura di eidolon letterario.
L’intreccio de Il nome della rosa si dipana attraverso una serie di omicidi che colpiscono i monaci dell’abbazia, apparentemente collegati alla consultazione di un misterioso libro. Tuttavia, la dimensione propriamente giallistica dell’opera costituisce il livello più superficiale di un’architettura narrativa molto più complessa, dove il vero oggetto dell’indagine non è l’identità dell’assassino, ma la natura stessa della verità e della conoscenza. Il susseguirsi degli eventi assume progressivamente i contorni di una farsa tragica, dove ogni tentativo di imporre un ordine razionale agli eventi si rivela vano di fronte all’irriducibile inconoscibilità del reale.
I personaggi di Eco ne Il nome della rosa si configurano come costrutti intellettuali piuttosto che come individualità psicologicamente definite. Guglielmo da Baskerville (controfigura di Guglielmo da Occam, filosofo inglese nominalista e riduzionista radicale) e Jorge da Burgos rappresentano due poli apparentemente opposti della razionalità e del fanatismo, ma in realtà incarnano forme uguali e contrarie della stessa hybris epistemologica. Guglielmo crede nella forza della logica, ma la sua fiducia è continuamente erosa dalla realtà ambigua del mondo; Jorge, custode cieco di un dogmatismo apocalittico, agisce per negazione, nel tentativo disperato di preservare una verità assoluta che non ammette ambiguità. Entrambi, sebbene in modo opposto, falliscono nel loro intento: la ragione non salva, la fede non illumina. Tanto Guglielmo quanto Jorge, nonostante le loro opposte filosofie, condividono quindi un’identica incapacità di attingere a una fede calda e genuina, sostituita nel primo caso da un razionalismo sterile, nel secondo da un fanatismo dogmatico. La loro complementarità simmetrica rivela come entrambi si collochino al di fuori della dimensione propriamente religiosa, configurandosi come varianti di un medesimo nichilismo mascherato. L’assenza di un autentico misticismo cristiano nell’opera non è casuale, ma riflette la visione di Umberto Eco di un universo privo di trascendenza, dove anche i rappresentanti della Chiesa sono ridotti a funzionari di un potere temporale o a cultori di sistemi filosofici astratti e la religione è in gran parte vissuta come sistema di potere, di censura e di controllo.
Il giovane Adso, testimone e narratore, è l’unico personaggio che attraversa l’opera senza imporsi, lasciando che la sua voce muti nel tempo e che l’insegnamento di Guglielmo diventi memoria malinconica. Ma anche Adso, che costituisce quindi il filtro narrativo attraverso cui il lettore accede agli eventi, nel passaggio dalla sua ingenuità giovanile alla prospettiva senile della rievocazione, dimostra di essere un esemplare paradigmatico del narratore inaffidabile.
È significativo come ne Il nome della rosa nessun personaggio possieda una fede cristiana autenticamente interiorizzata e viva: ciascuno è prigioniero di un’ideologia, di una paura, di un linguaggio. Gli altri monaci funzionano solo come maschere allegoriche dei vizi e delle virtù, privati tuttavia di qualsiasi dimensione spirituale autentica.
Umberto Eco ne Il nome della rosa sviluppa una riflessione multiforme sui rapporti tra potere e sapere, verità e interpretazione, fede e ragione. Il tema del libro proibito è declinato in chiave postmoderna, suggerendo che ogni forma di conoscenza è potenzialmente pericolosa e che la ricerca della verità può condurre alla distruzione. La questione ermeneutica pervade l’intera narrazione, dall’interpretazione dei sogni profetici di Adso alla decifrazione degli indizi dell’investigazione, fino alla lettura allegorica dell’Apocalisse.
Il riso, oggetto del libro conteso, assume valore di metafora della futilità di ogni tentativo umano di dare senso all’esistenza. Ma questa tesi è essa stessa insostenibile: "Se poi la verità è che tutto è da ridere, è da ridere (...) anche la teoria che afferma che tutto è da ridere, tutta da ridere dunque anche l'idea centrale di questo libro. È dunque ridicolo sostenere che tutto è ridicolo. Sarebbe ridicola allora anche per esempio l'intelligenza (...) o la scienza, che pure questo nominalismo riduce a dei puri giochi tra parole. E sarebbe allora ridicolo anche il dolore, l'ingiustizia e tanti tragici errori" che costellano da sempre la vita dell'uomo e della Storia umana [citazione tratta dalla recensione de Il nome della rosa apparsa ne "La Civiltà Cattolica", 19 settembre 1981].
La conflagrazione finale dell’abbazia rappresenta il trionfo del nichilismo cosmico che sottende l’intera opera. La distruzione della biblioteca costituisce la rivelazione dell’intrinseca vanità di ogni forma di sapere umano. Il fatto che il libro cercato si riveli essere una copia difettosa e lacunosa del secondo libro della Poetica aristotelica sottolinea l’ironia tragica di una ricerca che ha causato morti e distruzioni per un oggetto che si dimostra tanto insignificante quanto inaccessibile. L’epilogo, con Adso anziano che tenta di ricostruire i frammenti salvati dall’incendio, diventa una metafora della condizione postmoderna, dove la conoscenza si presenta sempre come frammentaria, provvisoria e inattendibile.
Eco impiega ne Il nome della rosa una funambolica orchestrazione di registri linguistici che spaziano dal latino ecclesiastico al volgare popolare, creando un effetto di straniamento che mima la distanza temporale mentre svela la sua artificiosità. L’uso del pastiche stilistico, dall’imitazione della cronaca medievale alla parodia del romanzo gotico, rivela l’influenza delle teorie postmoderne sulla letteratura come bricolage culturale. Le lunghe digressioni erudite, lungi dal costituire semplici inserti didascalici, funzionano come elementi di disturbo che interrompono il fluire narrativo per enfatizzare la natura costruita e artificiosa del testo. La tecnica del “manoscritto ritrovato” viene utilizzata ironicamente per problematizzare la questione dell’autenticità e dell’autorità testuale.
La straordinaria erudizione di Eco e la sua capacità di coniugare speculazione filosofica e tensione narrativa costituiscono indubbiamente i punti di maggior pregio de Il nome della rosa. Tuttavia, questa stessa erudizione si trasforma spesso in esibizione narcisistica, appesantendo il ritmo narrativo e risultando a tratti disturbante.
Il nome della rosa suscita, infatti, nel lettore un peculiare effetto di fascinazione e di connessa inquietudine, derivante dalla tensione tra la seduzione dell’erudizione e l’angoscia del vuoto metafisico che la sottende, come dimostra il celeberrimo esametro finale del romanzo: "Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus". La progressiva rivelazione dell’inconsistenza delle certezze razionali e religiose genera una forma di vertigine epistemologica che costituisce probabilmente l’effetto più duraturo della lettura.
Per quanto concerne la dimensione di romanzo storico insito nel Il nome della rosa, occorre precisare che l’operazione di ricostruzione compiuta da Eco presenta significative distorsioni che tradiscono un approccio ideologicamente orientato alla civiltà medievale. La rappresentazione del monachesimo benedettino risulta sistematicamente deformata in senso negativo, enfatizzando gli aspetti di corruzione, ignoranza e fanatismo a discapito della straordinaria fioritura culturale e spirituale che caratterizzò effettivamente l’esperienza monastica. La filosofia scolastica viene ridotta a sterile nominalismo, trascurando completamente la ricchezza speculativa della tradizione tomista e la sua capacità di sintesi tra ragione e fede. Il cristianesimo medievale appare nell’opera come un sistema di potere oppressivo e oscurantista, in contrasto con le acquisizioni della moderna storiografia che ha rivalutato il contributo della Chiesa alla conservazione e trasmissione del sapere classico. Questa sistematica denigrazione della cultura cristiana medievale riflette i pregiudizi di derivazione illuminista che Eco, nonostante la sua sofisticazione intellettuale, non riesce a superare, proiettando sulla realtà storica del XIV secolo le tensioni e le contraddizioni dell'età moderna, la cui cifra dominante è la secolarizzazione. La rappresentazione dell’Inquisizione come strumento di pura repressione intellettuale, per quanto contenga elementi di verità, ignora la complessità delle motivazioni teologiche e pastorali che la animarono, come hanno dimostrato i colossali studi sull'Inquisizione spagnola compiuti da Bartolomé Benassar, riducendo un fenomeno storico complesso a paradigma del dispotismo religioso.
Concludendo, Il nome della rosa è un’opera monumentale, straordinaria nella sua costruzione, potentemente destabilizzante nel suo messaggio. Ma è anche un testo che mette in scena un medioevo disumanizzato, dominato da paura, repressione e silenzio. La sua lettura, per quanto affascinante, non può prescindere da una cosciente assunzione critica: Eco non racconta il medioevo, ma lo reinventa per costruire una cupa allegoria della condizione moderna. La fede è assente, la verità è perduta, il sapere è destinato a essere sepolto sotto le macerie del linguaggio. Un romanzo che, sotto le spoglie di un’indagine medievale, consegna al lettore contemporaneo la vertigine di un mondo senza centro, senza Dio, e senza senso.


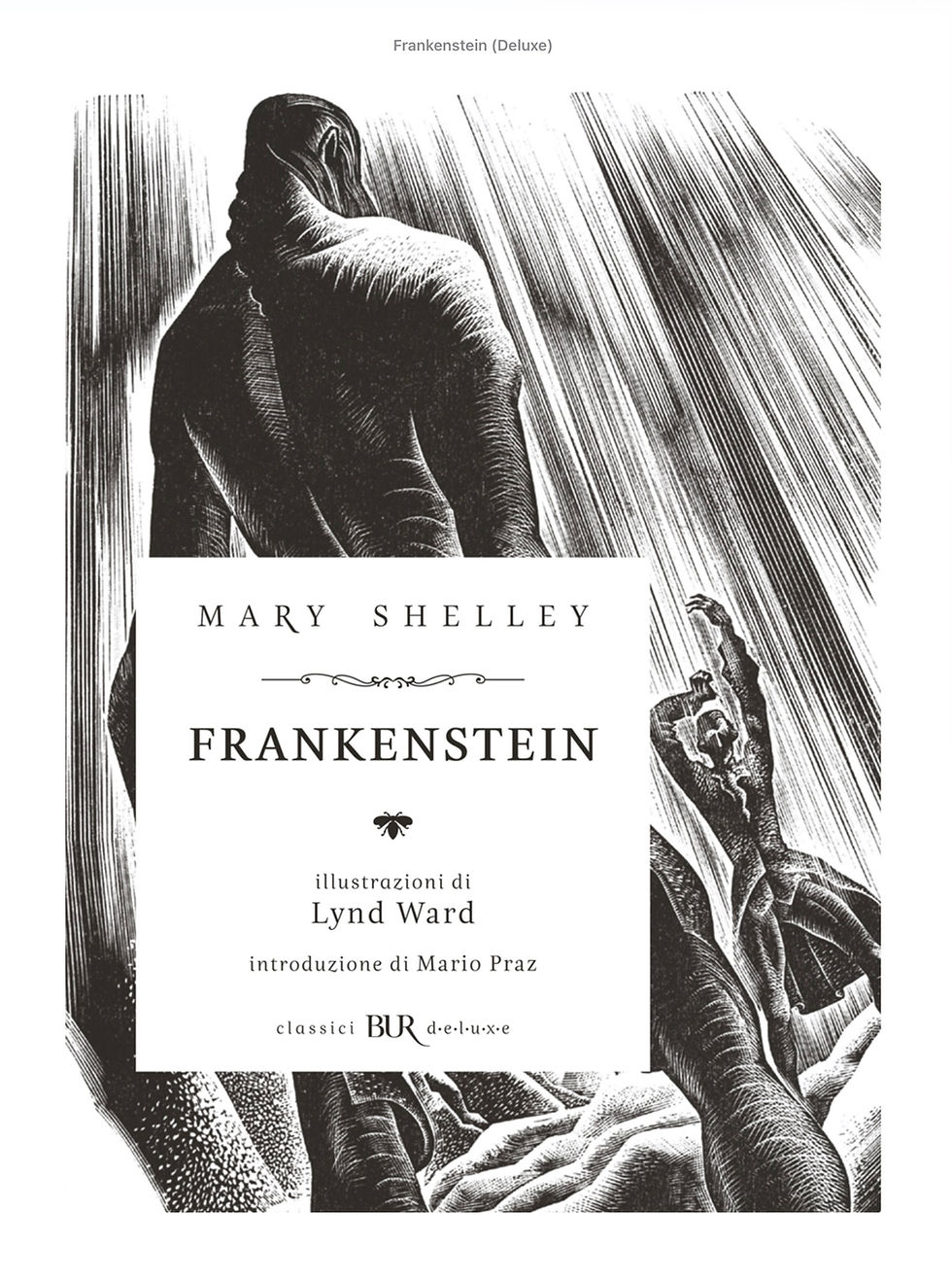

Commenti